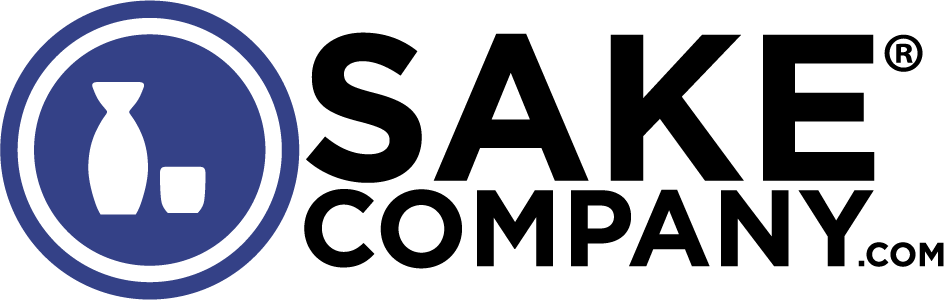Ogni volta che affronto un nuovo progetto legato alla miscelazione, sento la necessità di tornare alle fondamenta. La definizione di cocktail risalente al 1806 – distillato, acqua, bitter e zucchero – continua a rappresentare per me un punto di riferimento imprescindibile. È una struttura semplice, ma estremamente efficace, che ha dato origine a tutte le successive interpretazioni della mixology. Senza una solida comprensione di queste basi, qualsiasi tentativo creativo rischia di risultare vuoto o incoerente.
Nel mio lavoro, anche quando inserisco il sake in ricette contemporanee, non prescindo mai da questa grammatica classica. Un esempio emblematico è il manuale di Harry Johnson, il primo vero compendio del bartender moderno. Non si tratta solo di un ricettario: è un documento storico che raccoglie nozioni su tecniche di miscelazione, attrezzature, organizzazione del banco e gestione del food cost.
Ancora oggi, lo considero una fonte preziosa di ispirazione. Rileggere quelle pagine consente non solo di riscoprire cocktail dimenticati, ma anche di comprenderne la logica compositiva. Ed è proprio partendo da quella logica che diventa possibile reinterpretare i classici, inserendo il sake in modo coerente e rispettoso.

Dietro al banco: regole, presenza e accoglienza
Dietro al banco non ci si limita a preparare drink: si interpreta un ruolo, si comunica un’identità, si rappresenta un locale. È una dimensione che va oltre la tecnica, e che abbraccia presenza scenica, ascolto e senso di responsabilità. Il banco è il biglietto da visita immediato di ogni bar: dopo l’insegna, è il primo elemento con cui il cliente entra in contatto. Per questo motivo, ci sono alcune regole – semplici, ma fondamentali – che ogni professionista dovrebbe fare proprie.
La prima, su tutte, è l’accoglienza. Far sentire il cliente a proprio agio è il fondamento di un servizio di qualità. E su questo, la cultura giapponese è un esempio straordinario: nei cocktail bar in Giappone, l’ospitalità è codificata in ogni gesto, anche quando lo spazio è limitato o i tempi sono ristretti. Un’altra regola cruciale è la continuità della presenza al banco: lasciarlo incustodito, anche solo per qualche minuto, significa interrompere il flusso dell’esperienza. Ogni cliente deve poter contare su un punto di riferimento sempre visibile e disponibile, anche solo per una semplice richiesta o uno scambio di sguardi.
Infine, il comportamento. Dietro al banco non c’è spazio per tensioni o discussioni tra colleghi: proprio come in una sala riunioni davanti a un cliente, è necessario mantenere professionalità e compostezza. Il lavoro del bartender, spesso sottovalutato, richiede una preparazione mentale e relazionale profonda. Non basta saper miscelare: bisogna saper accogliere, leggere i segnali, adattarsi e offrire un’esperienza che vada oltre il contenuto del bicchiere.

Attrezzature e tecniche: il metodo giapponese
La cura nei dettagli, l’ordine e la precisione sono principi che accomunano la mixology giapponese e la filosofia che adotto quotidianamente al banco. Ogni strumento, ogni gesto, ogni sequenza ha uno scopo preciso. A partire dal jigger, che non è solo un misurino, ma uno strumento per garantire costanza e controllo. Utilizzare 25 o 50 ml con precisione millimetrica significa rispettare il bilanciamento del drink, ottimizzare i costi e ridurre gli sprechi. Oggi il jigger è spesso affiancato dai metal pourer, che offrono maggiore manualità senza rinunciare all’accuratezza.
L’equipaggiamento base del bartender comprende anche strumenti come il bar spoon – indispensabile per la miscelazione –, lo strainer per separare ghiaccio e liquido, e il fine strainer, utile a evitare che frammenti di ghiaccio alterino texture e diluizione del cocktail. Ci sono poi utensili legati a una logica di efficienza: il lime squeezer per gli agrumi, i biberon per sciroppi e premix, il muddler per pestare ingredienti freschi. Fino ad arrivare ai coltelli specializzati – come il tradizionale Deba – e alle pinze per garnish, che oltre a garantire igiene e pulizia, comunicano attenzione estetica.
La mixology giapponese insegna che ogni strumento va scelto e utilizzato in funzione della ricetta, del gesto e del risultato atteso. La differenza non è solo tecnica, ma culturale: riflette un rispetto profondo per la preparazione, per l’ospite e per la materia prima. Portare questo approccio nel proprio lavoro quotidiano significa elevare il livello di ogni servizio, anche nei dettagli che spesso passano inosservati.
Il sake come ingrediente liquido e culturale
Inserire il sake in un cocktail non è semplicemente una scelta tecnica: è un atto culturale. Significa confrontarsi con un prodotto complesso, dalle mille sfumature, che richiede rispetto, competenza e consapevolezza. Il sake non è un distillato e non è un vino: ha una struttura aromatica unica, spesso definita dall’umami, e una gamma di stili che spaziano dall’eleganza floreale di un ginjo alla rotondità lattica di un kimoto. La sua versatilità è indiscutibile, ma proprio per questo è necessario conoscerlo a fondo per evitare di sbilanciare o coprire il suo profilo.
Un errore comune è affiancarlo a distillati troppo invasivi, come un bourbon torbato o un rum agricolo particolarmente aggressivo. In questi casi, il sake rischia di sparire, perdendo completamente il suo contributo gustativo. Per questo, la merceologia diventa una competenza centrale: saper distinguere tra un daiginjo e un junmai, tra un nigori e uno yuzushu, significa poterli integrare in modo coerente nei cocktail, valorizzando le loro peculiarità senza snaturarle.
Inoltre, rispetto ad altri ingredienti, il sake introduce una dimensione “gastronomica” nel drink. In una preparazione liquida, dove mancano masticazione e consistenza, l’umami può rappresentare un ponte tra le sensazioni del palato e quelle di un piatto. In questo senso, il sake diventa non solo un ingrediente, ma un alleato per costruire cocktail tridimensionali, capaci di dialogare con il cibo o persino di sostituirlo in abbinamenti audaci.
Round building e coerenza nella miscelazione
Nel lavoro quotidiano dietro al banco, la precisione non riguarda solo le dosi o la tecnica, ma anche l’ordine operativo. È qui che entra in gioco il concetto di round building: un metodo di lavoro pensato per garantire efficienza, pulizia e costanza nel servizio. La regola è semplice, ma efficace: one bottle touch. Ogni bottiglia deve essere toccata una sola volta, ottimizzando i movimenti e riducendo gli sprechi di tempo. Questo approccio, che può sembrare meccanico, è in realtà un supporto prezioso soprattutto per chi è alle prime armi e deve sviluppare un metodo solido.
Il round building permette di gestire con lucidità anche momenti di servizio intenso. Stabilisce una sequenza logica per l’esecuzione dei drink, in base alla tecnica di preparazione. Ad esempio: si chiude per primo il drink build, poi lo shakerato, infine lo stir. Si tratta di una forma di disciplina, che non solo migliora l’efficienza, ma garantisce anche maggiore coerenza tra i cocktail serviti.
La logica dietro a questo metodo è strettamente collegata alla qualità finale. Anche piccoli errori – come invertire l’ordine degli ingredienti o ritardare l’aggiunta della parte gasata – possono compromettere l’equilibrio di un drink. In un contesto in cui si lavora con il sake, spesso delicato e sfuggente, l’ordine e la coerenza diventano ancora più importanti. Il round building, in questo senso, è uno strumento che consente di rispettare il prodotto, mantenendo alta la qualità anche in fase di produzione ripetuta.

Tecniche classiche: build, stir & strain, throwing
Nella costruzione di un cocktail, la tecnica di miscelazione non è una scelta secondaria: determina struttura, diluizione, temperatura e texture finale. Per questo è fondamentale padroneggiare le tecniche classiche — build, stir & strain, throwing — scegliendo quella più adatta in base alla ricetta, agli ingredienti e all’effetto desiderato nel bicchiere.
La tecnica build è la più semplice e diretta: si costruisce il drink direttamente nel bicchiere, versando gli ingredienti sopra il ghiaccio. È ideale per preparazioni leggere o highball, dove l’effervescenza va preservata. Ma anche qui nulla può essere lasciato al caso. Un errore diffuso, ad esempio, è sottovalutare il ruolo del ghiaccio: se galleggia, si scioglie troppo in fretta, portando a un’eccessiva diluizione. Raffreddare correttamente il bicchiere, dosare in modo preciso e mescolare con un movimento up & down aiuta a garantire un risultato equilibrato.
La tecnica stir & strain, invece, è pensata per cocktail che richiedono una diluizione controllata e una texture liscia, come un Martini o un Manhattan. Dopo aver raffreddato il mixing glass, si aggiungono ingredienti e ghiaccio, si miscela delicatamente e si filtra nel bicchiere precedentemente raffreddato. È una tecnica che valorizza la pulizia del drink e richiede una buona sensibilità nella miscelazione, soprattutto quando si lavora con distillati secchi o sake dalla struttura delicata.
Infine, il throwing è una tecnica scenica e funzionale, utilizzata per aerare e ossigenare il cocktail senza sovraccaricarlo di diluizione. È particolarmente indicata quando si vuole enfatizzare la leggerezza di un ingrediente, come uno sherry o un sake corposo. La precisione nel movimento, l’altezza del versaggio e la gestione del ghiaccio sono elementi chiave. Non si tratta solo di spettacolarità: se eseguita correttamente, questa tecnica aggiunge profondità e armonia al risultato finale.
La shakerata giapponese: armonia in tre tempi
Tra le tecniche di miscelazione, la shakerata occupa un posto centrale, ma non tutti i bartender ne colgono la complessità. Nella tradizione giapponese, esiste una variante codificata e meticolosa che si distingue per eleganza e rigore: la shakerata in tre tempi. Ogni fase ha uno scopo preciso — emulsione, diluizione, arieggiamento — e l’insieme dei gesti è studiato per garantire costanza e qualità, drink dopo drink.
Nel contesto di un cocktail bar, l’obiettivo non è solo realizzare un buon drink, ma assicurare che ogni replica della ricetta risulti identica alla precedente. In questo senso, la shakerata giapponese rappresenta un modello di coerenza. I bartender giapponesi arrivano persino a contare il numero di cubetti inseriti nello shaker, a regolare l’intensità del movimento e a controllare l’orientamento del ghiaccio, affinché nulla venga lasciato al caso.
Questa tecnica non è fine a sé stessa. È il frutto di una cultura professionale che considera ogni gesto parte integrante dell’esperienza. La shakerata in tre tempi restituisce un cocktail equilibrato, stabile e pulito. Soprattutto, dimostra che anche un gesto apparentemente semplice può diventare una forma di disciplina artigianale. Personalmente, non utilizzo questa shakerata per tutti i drink, ma in alcuni casi specifici — ad esempio con sake fruttati, nigori o bottiglie ad alta gradazione — può essere un’arma decisiva per preservare le caratteristiche aromatiche del prodotto.

Ghiaccio, temperatura e diluizione, scienza e servizio
Nel mondo del bartending, il ghiaccio è spesso sottovalutato. In realtà, rappresenta una delle variabili più decisive per la riuscita di un cocktail. La sua funzione non si limita a raffreddare: regola la diluizione, condiziona la texture, incide sul bilanciamento finale.
Non esiste raffreddamento senza diluizione — è una regola fisica, oltre che professionale — ed è proprio da questa consapevolezza che si deve partire.
Un esempio concreto è il cosiddetto ghiaccio “double frozen”, conservato a temperature troppo basse (fino a -25°C). A quelle condizioni, il ghiaccio risulta opaco e poco reattivo: impiega troppo tempo a fondersi, compromettendo la velocità e l’efficacia della diluizione. In un Martini, ad esempio, questo può tradursi in un cocktail sbilanciato e servito a una temperatura non ottimale. Il ghiaccio va quindi “umanizzato”: lasciato stemperare fino a raggiungere i 0°C, oppure inumidito per riportarlo alla sua condizione funzionale.
Anche la forma del ghiaccio è determinante. Un cubo ha superfici e spigoli che accelerano lo scioglimento; una sfera, invece, conserva la temperatura più a lungo ma richiede maggiore precisione nel taglio e nella gestione.
A questi aspetti si aggiungono parametri come la qualità dell’acqua, la superficie di contatto, il tempo di permanenza nel mixing glass e la temperatura dell’ambiente.
Tutti fattori che, se ben calibrati, permettono di garantire un risultato costante e professionale.
Con liquidi a -40°C e ghiaccio a -10°C il ghiaccio non si diluisce neanche un pò. Ci sarà una fase dove si andrà verso l'equilibrio termico (una sorta di media tra -40 e -10, dove a tutti gli effetti il ghiaccio scalda il liquido), ma successivamente la temperatura ambiente scalderà il bicchiere e siccome il ghiaccio ha un rapporto volume/superficie a favore del volume (se è un buon cubo o sfera) ha maggiore inerzia termica e sarà poi lui a mantenere la temperatura del bicchiere bassa nel tempo.
Il cubetto trasparente che si scioglie, è trasparente perchè il velo di acqua che si scioglie perchè scambia calore con l'esterno è a zero gradi, ma c'è un gradiente di temperatura verso l'interno dove al centro lui magari è a -20 ancora. Infatti, l'acqua ha un'inerzia termica importante.
Per quanto riguarda il ghiaccio opacizzato, in Giappone estraggono il ghiaccio e lo tengono a temperatura ambiente (o lo bagnano), per due motivi: è troppo freddo e, come dicevo, se è a -40 non si diluisce nel drink, raffredda e basta, ma non cede liquido, perchè non si scioglie. In secondo luogo, sul ghiaccio opaco ci sono infiniti "cristalli minuscoli" che sono come delle punte, infiniti punti di nucleazione.
Mettendo quel ghiaccio nel bicchiere e versandoci sopra una bevanda gasata, "spaccano" tutta la CO2, con conseguente perdita della bolla.
Drink d'autore: i cocktail presentati in masterclass
Ecco quattro cocktail concepiti per valorizzare il sake in modo tecnico, coerente e creativo. Ogni ricetta nasce da un dialogo costante tra merceologia e sensibilità gustativa, partendo sempre da un classico della miscelazione per poi costruire una variazione identitaria, precisa e studiata nei dettagli.
Sakura è un twist sul Gimlet che omaggia il fiore simbolo del Giappone. La struttura è quella di un Martini addolcito e reso più accessibile grazie all’aggiunta di un cordiale di sakura, preparato con una polvere di fiori giapponesi, zucchero, acido citrico e acido malico. A bilanciare, un gin giapponese (Roku), un vermuth dry e 50 ml di sake Junmai Dewanoyuki Kimoto. Il risultato è floreale, gentile, ma con una profondità inaspettata: perfetto sia per l’aperitivo sia per accompagnare dessert delicati.
Crisantemo è invece una rivisitazione concettuale di un classico cocktail del Savoy Hotel. La combinazione di sake Kodakara Umeshu, sherbet di crisantemo, gocce di assenzio e Dom Bénédictine crea un drink aromatico, erbaceo e dalla componente amaricante sottile. È un cocktail dal carattere più gastronomico, pensato per chi cerca nel drink un’esperienza quasi da meditazione, con una costruzione stratificata che ricorda la complessità di un vermuth cocktail, ma con un'identità marcatamente orientale.
Ringo Togarashi rielabora il Bamboo cocktail sostituendo lo sherry con un sake agrumato (Dewazakura Junmai) e introducendo un cordiale di mela verde aromatizzato al togarashi, una miscela di spezie giapponesi nota anche come shichimi togarashi, è composta da pepe di Sichuan, peperoncino rosso, zenzero macinato, alga nori, sesamo bianco e nero tostato, semi e buccia di arancia. Viene utilizzata per insaporire zuppe, pasta, carne alla griglia, sushi, yakitori e frutti di mare.
Il risultato è una miscela sorprendente, in cui dolcezza fruttata e piccantezza delicata si rincorrono in equilibrio dinamico. Un cocktail che accompagna bene piatti crudi o speziati, grazie alla sua struttura leggera ma decisa.
Infine, Ginger chiude la degustazione con un omaggio al Penicillin. Qui il sake si affianca a un bourbon strutturato, completato da angostura e fake lime (una soluzione acida composta da acqua, acido citrico e malico). Il Kodakara Dry Ginger funge da elemento centrale, conferendo vivacità speziata e tenuta aromatica anche dopo la shakerata. È un drink forte, secco, ma reso più fresco e accessibile grazie al bilanciamento fra piccantezza, acidità e struttura alcolica.
Ogni cocktail è frutto di prove ripetute, test di bilanciamento e attenzione maniacale alla coerenza tra ingredienti e tecnica. Il sake, in tutte le sue declinazioni, non è mai un semplice sostituto, ma un attore protagonista in grado di ridefinire l’identità del drink.
Creatività, studio e rispetto del sake
Portare il sake nel mondo della miscelazione contemporanea richiede un approccio consapevole, che unisca tecnica, cultura e sensibilità. Non si tratta di inserire un ingrediente esotico per moda o tendenza, ma di comprenderne a fondo le caratteristiche, i limiti e le potenzialità. Durante questa masterclass ho cercato di trasmettere un messaggio chiaro: il sake non è solo un alcolico da abbinare, ma una materia prima da interpretare con rispetto.
Ogni drink che ho presentato è il risultato di studio, tentativi, errori e correzioni. Ma soprattutto, nasce da un processo che parte sempre dallo stesso punto: conoscere bene i classici, saper leggere gli ingredienti e applicare tecniche coerenti. Solo così si può creare una nuova grammatica, dove il sake entra con pieno diritto nel linguaggio della mixology moderna.
La sfida non è inventare qualcosa di spettacolare, ma mantenere equilibrio, coerenza e identità. E se c’è un elemento che lega ogni tecnica, ogni scelta, ogni variazione, è la volontà di offrire un’esperienza autentica a chi si siede al banco.
Perché, in fondo, la vera innovazione non nasce dall’improvvisazione, ma dalla capacità di ascoltare il prodotto, valorizzarlo e raccontarlo con precisione.